La mia Africa (1985)
- michemar

- 23 mag 2024
- Tempo di lettura: 5 min
Aggiornamento: 3 ott 2025

La mia Africa
(Out of Africa) USA/UK 1985 dramma 2h41’
Regia: Sydney Pollack
Soggetto: dagli scritti di Karen Blixen, libri di Isak Dinesen, Errol Trzebibnski, Judith Thurman
Sceneggiatura: Kurt Luedtke
Fotografia: David Watkin
Montaggio: Fredric Steinkamp, William Steinkamp, Pembroke J. Herring, Sheldon Kahn
Musiche: John Barry
Scenografia: Stephen B. Grimes
Costumi: Milena Canonero
Meryl Streep: Karen Blixen
Robert Redford: Denys Finch-Hatton
Klaus Maria Brandauer: Bror von Blixen - Finecke
Michael Kitchen: Reginald Berkeley Cole
Malick Bowens: Farah
Joseph Thiaka: Kamante
Stephen Kinyanjui: capo Kinanjui
Michael Gough: Baron Delamere
Suzanna Hamilton: Felicity
Rachel Kempson: Lady Belfield
Graham Crowden: Lord Belfield
Leslie Phillips: sir Joseph
Shane Rimmer: Belknap
TRAMA: Karen arriva in Kenya nel 1914 per ritrovarvi il barone von Blixen, da lei sposato senza amore. Durante le lunghe assenze del marito, fa amicizia con Denys Finch-Hatton, un cacciatore di elefanti. Quando il barone le trasmette la sifilide, Karen rientra in Europa per curarsi. Poi tornerà nel continente africano.
Voto 7,5

Guardando questo film qualche decennio dopo la sua uscita si potrebbe avere l’impressione che l’entusiasmo suscitato a suo tempo era alquanto esagerato. Però attenzione: non c’è dubbio che questa sia una festa per gli occhi e per le orecchie. L’abbinamento della lussureggiante colonna sonora di John Barry con la poetica fotografia di David Watkin vale il prezzo del biglietto. Così come la storia, basata sulle memorie di Isak Dinesen (il nome d’arte di Karen Blixen), merita solo elogi. Inoltre, non c’è niente di sbagliato: la regia di Sydney Pollack è sicura e competente e la recitazione di Meryl Streep e Robert Redford è di prim’ordine. Ma la storia è pigra e risulta poco più di un ordinario melodramma che ribolle senza mai raggiungere l’ebollizione. A dire il vero, durante le quasi tre ore di durata del film, si viene conquistati più dalla scenografia e dal commento musicale che dai personaggi. Eppure, in gran parte a causa dell’emozione coinvolgente dell’insieme, la pellicola è diventata il film per eccellenza e di prestigio per quella stagione e l’Academy lo ha trattato come tale.

Sydney Pollack utilizza lo stile che avevamo riscontrato nei film di David Lean, con l’aggiunta dello sguardo bucolico di Terrence Malick come modello, e a tanti anni di distanza pare evidente come in un primo momento, per la lunghezza e il tormento che comprendeva, il film pareva essere assegnato alla direzione proprio di Lean. La differenza principale tra questo film e il meglio del regista londinese (come accadeva in Lawrence d’Arabia) è a proposito della profondità e dell’ampiezza. Lean aveva il gran pregio di non perdere mai di vista i personaggi: Pollack, invece, si limita all’essenziale: parla di due personaggi, del loro amore reciproco e del luogo in cui vivono, e non molto altro. Sebbene la storia progredisca attraverso la Prima guerra mondiale, il trattamento del conflitto è superficiale ed al massimo è materiale di sfondo. In altre parole, è come se i suoi personaggi principali siano isolati dal resto del mondo e da ciò che vi accade. È vero che siamo in piena Africa e tutto pare lontanissimo, però loro sono occidentali e si avverte l’impressione, anche se distratti dalla relazione, che siano al di fuori del tempo e dello spazio, in qualche piccolo angolo del mondo non toccato dalla marcia del progresso umano e dalle questioni belliche.
La sceneggiatura, meticolosamente studiata, si basa sulle storie vere di Karen Blixen (Meryl Streep) che ha vissuto in una piantagione di caffè in Kenya a partire dal 1913, appena sposata con il suo migliore amico, il barone Bror von Blixen (Klaus Maria Brandauer). Mentre era lì, ha gestito la fattoria, che era sempre sull’orlo della bancarotta, ha divorziato da suo marito dopo numerosi casi di infedeltà da parte sua e si è impegnata in una storia d’amore a lungo termine con l’avventuriero Denys Finch-Hatton (Robert Redford). Dopo il fallimento della piantagione nel 1931, tornò nella sua nativa Danimarca, dove divenne un’autrice di fama mondiale (uno dei suoi libri più noti fu Il pranzo di Babette, su cui si basa l’omonimo film). La trama si concentra sul periodo tra il 1913 e il 1931, con particolare enfasi sul rapporto tra Karen e Denys. L’approccio di Pollack alla storia d’amore è sobrio e intellettuale. Mentre i suoi attori sono al top del loro potenziale e i loro personaggi sono ben resi, non si avverte mai la passione che lo spettatore crede di veder realizzata, forse perché la semplice e naturale emotività umana si perde nella grandezza o nelle pretese di quella grandezza cercata.
Ciò che si fa veramente amare è l’interpretazione che Meryl Streep e Robert Redford riescono a fornire, da par loro, ed è di questa reale esibizione recitativa, oltre al panorama e alle musiche, che si resta incantati. Senza dimenticare quale intesa ci sia sempre stata tra l’attore e il regista, quanti film hanno orchestrato assieme. Oltre al valente, ottimamente scelto, Klaus Maria Brandauer e ad altri caratteristi di riconosciuta esperienza, impossibile non far cenno di quella che è forse la maggiore protagonista del film: l’Africa e la sua imponente bellezza, a cominciare dalle mandrie della fauna locale fotografate da terra (vedi il safari) o dall’alto quando i due volano con l’aereo di Denys. Chi contribuisce poi al successo definitivo è il musicista John Barry, che, si può affermare, sposta gli equilibri sui giudizi e sulla emozione che quelle note fanno provare. Consapevole del potere di tali sequenze, Pollack si permette di indugiare su questi aspetti senza la fretta di tornare all’interazione tra Karen e Denys, che discutono continuamente di quel loro rapporto che resta mai veramente compiuto.
Quella relazione è così incompiuta che la scena che suscita il maggior erotismo resta quella in cui Denys lava i capelli di Karen, e su come questo momento apparentemente innocente sia carico di sensualità. La sequenza è ben girata ed è probabilmente l’unico momento durante il quale a Meryl Streep è permesso di apparire attraente e trasmette innegabilmente il senso di intimità più profondo tra i personaggi. La sequenza fa anche ciò che ogni regista sogna di realizzare: creare il collegamento emotivo tra i personaggi ed il pubblico. Siamo lì con loro in quel momento, non li guardiamo distanti ma con loro.
Bravissimi gli attori, grandi i pregi del lavoro del cast tecnico, la regia è comunque all’altezza e il film venne riconosciuto come il migliore e pertanto premiato: ancora oggi emoziona e appassiona. In fondo, era l’obiettivo dei produttori.
Riconoscimenti
1986 - Premio Oscar
Miglior film
Miglior regista
Miglior sceneggiatura non originale
Migliore fotografia
Migliore scenografia
Miglior sonoro
Miglior colonna sonora
Candidatura per la miglior attrice a Meryl Streep
Candidatura per il miglior attore non protagonista a Klaus Maria Brandauer
Candidatura per i migliori costumi
Candidatura per il miglior montaggio
1986 - Golden Globe
Miglior film drammatico
Miglior attore non protagonista a Klaus Maria Brandauer
Miglior colonna sonora
Candidatura per il miglior regista
Candidatura per la miglior attrice in un film drammatico a Meryl Streep
Candidatura per la miglior sceneggiatura
1987 - Premio BAFTA
Migliore sceneggiatura non originale
Migliore fotografia
Miglior sonoro
Candidatura per la miglior attrice protagonista a Meryl Streep
Candidatura per il miglior attore non protagonista a Klaus Maria Brandauer
Candidatura per i migliori costumi
Candidatura per la miglior colonna sonora





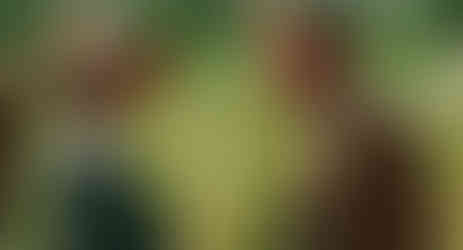



















Commenti